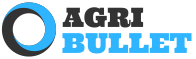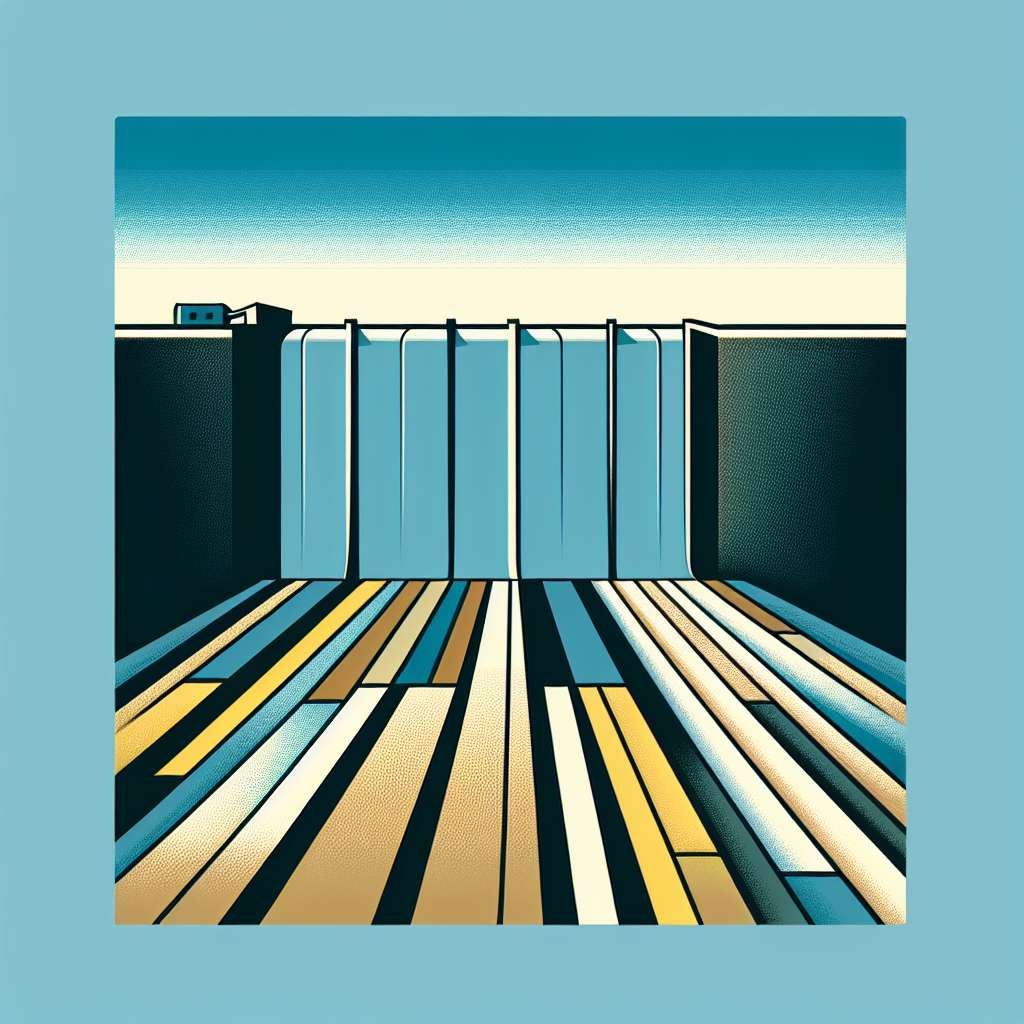E-Mail: [email protected]
- Modena: +15,5% valore aggiunto pro-capite tra il 2015 e 2021.
- Modena: 29 certificazioni di qualità, incluse 14 DOP e 13 IGP.
- Ghedi: sequestrati 9.600 metri quadrati, appalti da 7 milioni di euro.
Modena: un modello agroalimentare sotto osservazione
La provincia di Modena, rinomata per la sua solida economia nel settore agroalimentare, si trova oggi a fronteggiare sfide demografiche crescenti che mettono a dura prova il suo equilibrio. Un’analisi approfondita, condotta dalla Fondazione Osservatorio Agromafie in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena e Coldiretti, ha rivelato che, sebbene il territorio rappresenti un asset strategico del Nord Italia grazie alla sua vocazione all’export e alla ricchezza delle sue produzioni di qualità, persistono zone d’ombra che necessitano di un’attenta valutazione. Il valore aggiunto pro-capite della provincia, costantemente al di sopra della media regionale e nazionale, ha registrato una crescita del 15,5% tra il 2015 e il 2021. Tuttavia, le dinamiche demografiche sollevano serie preoccupazioni per il futuro.
L’agricoltura modenese, che si estende su oltre 122.000 ettari di terra coltivata, è principalmente dedicata alla coltivazione di foraggere (45%) e cereali (29%), riflettendo la notevole presenza dell’allevamento da latte e delle produzioni DOP. La produzione agricola complessiva supera i 21 milioni di quintali annui, con una notevole varietà che include uva per vini pregiati, frutta di alta qualità come pere, ciliegie e susine, ortaggi e colture tuberose. Il settore zootecnico, che conta più di 3.200 allevamenti, conferma una catena produttiva robusta, sostenuta da 24 macelli distribuiti sul territorio. Le aziende a conduzione familiare costituiscono l’84% del tessuto produttivo, con un’alta concentrazione nelle coltivazioni seminative e permanenti e una predominanza di imprese di piccole dimensioni economiche.
Il settore agroalimentare modenese, che si distingue per la qualità certificata delle sue produzioni, vanta ben 29 certificazioni di qualità, tra cui 14 DOP, 13 IGP e 2 STG. Questa abbondanza è sostenuta da una solida infrastruttura produttiva, con 4.604 imprese attive *iscritte negli archivi dell’industria alimentare e delle bevande al 31 marzo 2024. Tuttavia, questo scenario apparentemente idilliaco nasconde insidie legate alla crescente infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti e, di conseguenza, nell’utilizzo improprio del compost.
Un campanello d’allarme è stato lanciato dall’analisi dei flussi di compost utilizzato nelle tenute agricole. La comparsa di coltivazioni inconsuete, come il triticale, che viene poi ceduto a terzisti e utilizzato come biocombustibile, potrebbe indicare una ricerca di credito attraverso canali estranei agli intermediari finanziari, un tentativo di infiltrazione mafiosa. Il compost, in particolare, si presenta come un residuo delle lavorazioni dei rifiuti, e quindi come il risultato di un settore in cui la presenza della criminalità organizzata è da tempo una realtà accertata. Le imprese che operano illegalmente hanno l’esigenza di smaltire il compost derivante da fonti non del tutto lecite e talvolta non ancora completamente trasformato in fertilizzante; i campi agricoli rappresentano una delle vie utilizzate per cedere questo materiale, talvolta in abbinamento a prestiti economici offerti agli imprenditori agricoli in difficoltà, i quali, prestandosi a tale pratica, finiscono poi per subirne le conseguenze.
Le tattiche di infiltrazione sono ripetitive e rivelano delle vulnerabilità. Il timore dell’imprenditore di mostrare una situazione finanziaria precaria lo spinge a cercare fondi attraverso vie non convenzionali, in segreto, credendo di essere più astuto degli altri. In questo modo, ci si trova intrappolati in un circolo estremamente pericoloso.
- 🌱 Ottimo articolo! Finalmente si fa luce su... ...
- 😡 Agromafie, una vergogna! Ma cosa possiamo fare...?...
- 🤔 Interessante il legame tra rifiuti e agricoltura, ma... ...
La piaga del traffico illecito di rifiuti in Italia
Il traffico illecito di rifiuti rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali e sociali che affliggono l’Italia. Nonostante un’apparente diminuzione dei roghi dolosi nei centri di raccolta, la gestione illegale dei rifiuti rimane una problematica diffusa, con serie ripercussioni sull’ambiente, la salute pubblica e l’economia. Questa condotta criminale consiste nella gestione e nello smaltimento non autorizzato di rifiuti industriali, tossici o pericolosi, principalmente per ragioni economiche. Le imprese disoneste riducono i costi di smaltimento affidandosi a soggetti legati alla criminalità organizzata.
I rifiuti illeciti spesso vengono seppelliti in discariche abusive, incendiati per eliminare rapidamente grandi quantitativi di materiali, o trasportati in paesi esteri con minori controlli ambientali. Uno degli esempi più tristemente noti di questo fenomeno è la “Terra dei Fuochi“, un’area compresa tra le province di Napoli e Caserta, dove per decenni la criminalità organizzata ha gestito un vasto traffico di rifiuti pericolosi, sotterrandoli in discariche abusive o bruciandoli senza alcun controllo. Tali pratiche hanno generato una vera e propria crisi ambientale e sanitaria, con un notevole aumento di patologie respiratorie, tumori e disturbi cardiovascolari tra la popolazione residente. Tra le località più colpite figura Acerra, da anni al centro di numerose indagini sullo smaltimento illegale di scarti industriali provenienti da ogni parte d’Italia.
In concreto, non veniva effettuato alcun processo di purificazione dei residui vegetali.
Il materiale, non avendo subito i trattamenti necessari, si presentava quindi inadatto all’uso e da considerarsi rifiuto, a causa della contaminazione da plastiche e idrocarburi con livelli persino superiori di diverse volte ai limiti consentiti.
Un motivo di forte preoccupazione è rappresentato dalla situazione dell’agricoltura locale: numerosi appezzamenti sono stati contaminati dalla disseminazione illegale di sostanze nocive, compromettendo la salubrità degli alimenti destinati alla vendita.
Tutto ciò ha avuto un impatto negativo non solo sulla salute pubblica, ma ha anche indebolito il tessuto economico del territorio, ponendo in serie difficoltà le aziende agricole che operano nel rispetto delle norme.
La gravità della situazione ha spinto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) a emettere una sentenza storica, condannando l’Italia per non aver implementato misure appropriate per tutelare la vita e la salute degli abitanti della “Terra dei Fuochi”.
Il tribunale ha ordinato al governo italiano di agire prontamente, predisponendo interventi concreti per risanare le zone contaminate e assicurare ai residenti informazioni chiare sui livelli di inquinamento e sui pericoli per la salute.
Di recente, sono stati avviati progetti di bonifica in tre siti emblematici: Agrimonda a Marigliano, l’ex Pozzi Ginori nell’Agro Caleno e Calabricito ad Acerra.
Secondo la Commissione bilaterale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, i roghi dolosi di rifiuti sono diminuiti dai 2.220 casi del 2019 ai 1.044 del 2022, ma il problema non è affatto risolto. Le investigazioni rivelano una intensa pratica di traffico illegale che coinvolge diverse regioni italiane e si estende oltre i confini nazionali, in direzione di nazioni come Tunisia, Albania, Montenegro e Slovacchia. Il porto di Bari si conferma un cruciale punto di smistamento per questo commercio illegale.
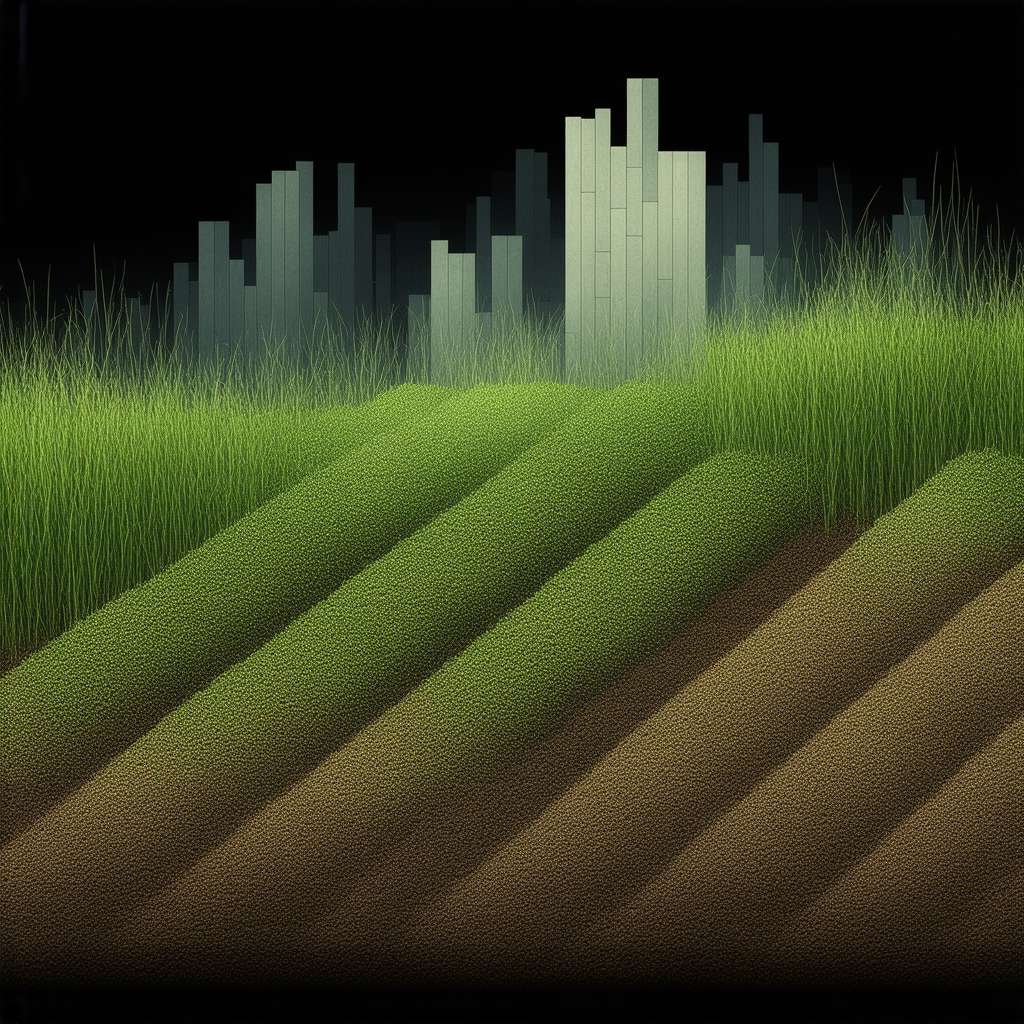
Ghedi: un caso emblematico nel bresciano
Un’operazione condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri a Ghedi, in provincia di Brescia, ha portato al sequestro di un impianto di compostaggio situato su una superficie di circa 9.600 metri quadrati. L’amministratore unico della società è indagato per il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti. Le indagini hanno rivelato che l’azienda, attraverso specifici contratti d’appalto stipulati con diverse società multiutility tra il 2019 e il 2024, che le hanno fruttato oltre 7 milioni di euro, avrebbe ritirato circa 250.000 tonnellate di rifiuti vegetali con l’impegno di sottoporli a un trattamento che ne rimuovesse materiali estranei come plastica, vetro e metalli, trasformandoli in ammendanti utili per l’agricoltura. In realtà, l’operazione non era finalizzata a massimizzare i profitti. Di fatto, nulla veniva fatto per depurare gli scarti vegetali.
Il materiale, non sottoposto ai necessari processi, risultava così inadeguato e classificabile come rifiuto, in quanto contaminato da plastiche e idrocarburi con concentrazioni fino a 12 volte superiori ai limiti di legge. Veniva poi ceduto a titolo gratuito o a un costo simbolico di 1 euro per tonnellata ad altri agricoltori, ai quali era fraudolentemente presentato come fertilizzante, sebbene privo dei requisiti legali previsti a tale scopo, configurandosi di fatto come smaltimento illegale su terreni agricoli. I controlli da parte dei carabinieri forestali proseguiranno al fine di salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza sia per l’ambiente che per le persone residenti in provincia di Brescia.
Strumenti e strategie per contrastare le agromafie
La lotta al traffico illecito dei rifiuti richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini. Le istituzioni devono rafforzare i controlli con l’impiego di tecnologie avanzate, investire in impianti di trattamento e riciclo per garantire un corretto smaltimento, e promuovere la cultura del riciclo e della legalità, sensibilizzando i cittadini sui rischi connessi al traffico illecito. Come consumatori, possiamo contribuire segnalando attività sospette alle autorità, adottando comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti, e preferendo aziende e servizi che garantiscono processi di smaltimento certificati e sostenibili.
Dopo anni di tentativi infruttuosi con il sistema Sistri, oggi la lotta contro lo smaltimento illecito si affida al Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Questo nuovo strumento, sotto la responsabilità diretta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si propone di digitalizzare il controllo dei movimenti dei rifiuti, rendendo più difficile la falsificazione della documentazione relativa a trasporto e smaltimento.* Il Rentri prevede che le imprese che gestiscono rifiuti speciali e pericolosi si conformino entro il 13 febbraio 2025, mentre gli altri operatori del settore seguiranno scadenze progressivamente stabilite fino a febbraio 2026. Tale innovazione, se attuata correttamente, potrebbe finalmente arginare le attività criminali connesse al ciclo dei rifiuti.
Prospettive future: un’agricoltura consapevole e resiliente
Dopo aver analizzato le complesse dinamiche che legano il settore agroalimentare, la criminalità organizzata e la gestione dei rifiuti, è fondamentale delineare strategie per un futuro agricolo più sostenibile e sicuro. Per affrontare questa sfida, è essenziale riscoprire un principio cardine dell’agricoltura: la rotazione delle colture. Questa pratica, che consiste nell’alternare diverse specie vegetali sullo stesso terreno nel corso del tempo, non solo migliora la fertilità del suolo, ma contribuisce anche a ridurre la dipendenza da fertilizzanti esterni e a prevenire l’accumulo di patogeni e parassiti. Una corretta rotazione delle colture, combinata con l’utilizzo di compost di qualità certificata, può rappresentare una valida alternativa all’impiego di fertilizzanti chimici, riducendo al contempo il rischio di infiltrazioni criminali nel ciclo dei rifiuti.
Parallelamente, è necessario promuovere l’adozione di tecnologie agricole avanzate, come l’agricoltura di precisione. Grazie all’utilizzo di sensori, droni e sistemi di analisi dei dati, è possibile monitorare costantemente lo stato di salute delle colture, ottimizzare l’irrigazione e la fertilizzazione, e individuare tempestivamente eventuali anomalie o segni di contaminazione. L’agricoltura di precisione, combinata con la tracciabilità dei prodotti agricoli lungo tutta la filiera, può contribuire a garantire la sicurezza alimentare e a proteggere la reputazione del Made in Italy.
Amico lettore, ti invito a riflettere su quanto hai appreso. La connessione tra agricoltura, rifiuti e criminalità non è un problema lontano, ma una sfida che ci riguarda tutti da vicino. Ogni volta che scegliamo un prodotto alimentare, ogni volta che gestiamo i nostri rifiuti, stiamo contribuendo a plasmare il futuro del nostro territorio. Sostenere le aziende agricole oneste, adottare comportamenti responsabili e informarsi sui processi di produzione e smaltimento sono azioni concrete che possiamo intraprendere per contrastare le agromafie e promuovere un’agricoltura più giusta e sostenibile. Il cambiamento parte da noi, dalla nostra consapevolezza e dalla nostra capacità di agire come consumatori responsabili.
- Report completo sull'economia di Modena, legalità e infiltrazioni malavitose.
- Approfondimenti sulle certificazioni alimentari e il loro impatto sul settore.
- Approfondimento sulla permeabilità dell'agromafia nel modenese, dati e analisi.
- Pagina della Camera di Commercio di Modena sulle eccellenze agroalimentari locali.