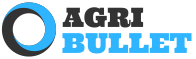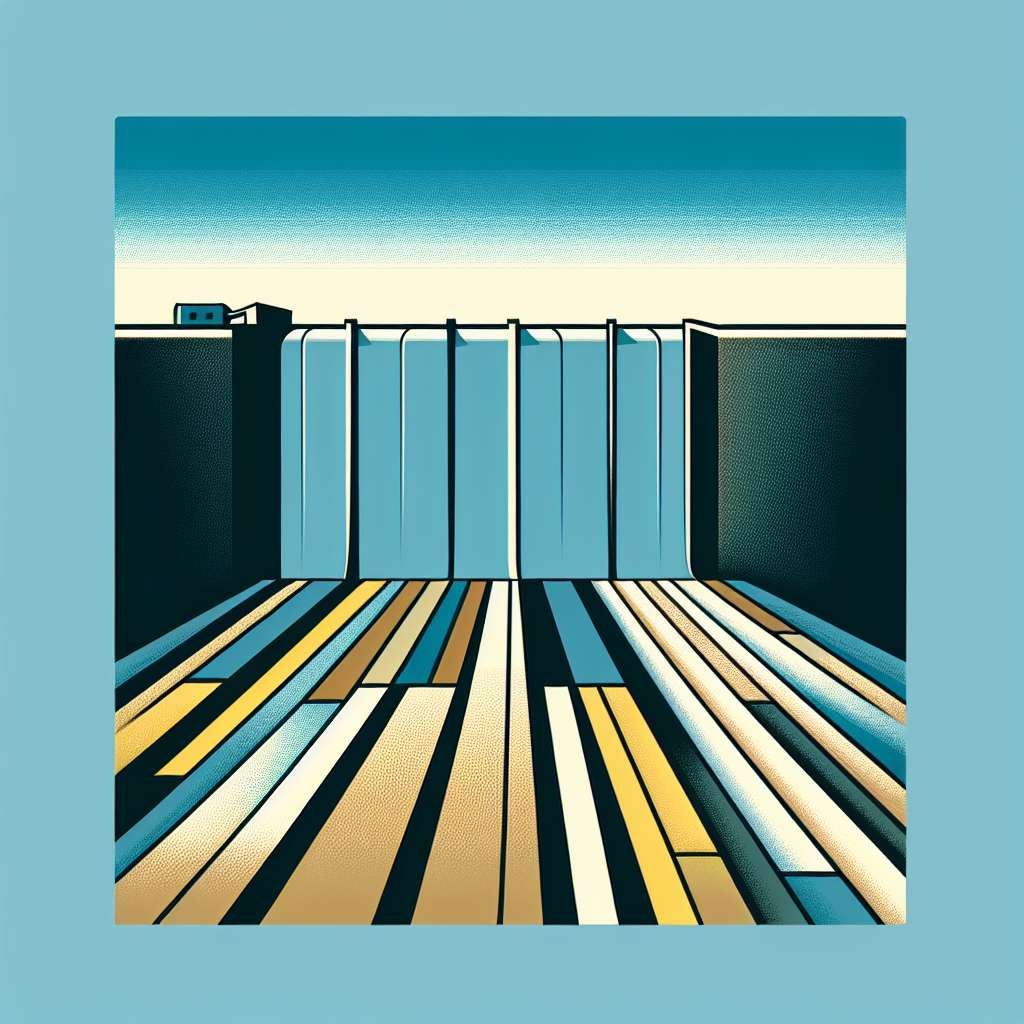E-Mail: [email protected]
- Vendite di vino in calo: -7% in Italia, -34% in Portogallo.
- Oscar Farinetti propone il 100% di prodotti italiani biologici.
- La distillazione di crisi favorisce i grandi produttori a discapito dei piccoli.
Il paradosso del vino nell’era del gray deal europeo
Il settore vitivinicolo europeo si trova oggi di fronte a una sfida complessa, un vero e proprio paradosso che mette in discussione le fondamenta stesse delle politiche agricole dell’Unione Europea. Mentre da un lato si promuove una transizione ecologica e sostenibile, con ambiziosi obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale e di conversione all’agricoltura biologica, dall’altro ci si scontra con una realtà fatta di crisi di sovrapproduzione, misure emergenziali e difficoltà concrete per i produttori. La cosiddetta “distillazione di crisi”, un intervento finanziato con fondi pubblici che consiste nel ritirare dal mercato il vino invenduto per trasformarlo in alcol industriale, rappresenta plasticamente questa contraddizione. È una soluzione tampone, un palliativo che non affronta le cause profonde del problema e che rischia di perpetuare un sistema insostenibile.
La distillazione di crisi, pur offrendo un temporaneo sollievo economico ad alcuni produttori, solleva interrogativi sulla sua efficacia a lungo termine. È davvero la strategia più appropriata per gestire le eccedenze di vino? Non sarebbe più opportuno intervenire a monte, agendo sulle cause della sovrapproduzione e promuovendo un modello agricolo più equilibrato e rispettoso dell’ambiente? Le critiche a questa misura si concentrano soprattutto sullo spreco di risorse pubbliche che essa comporta e sull’incentivo implicito a continuare a produrre senza tenere conto delle reali dinamiche del mercato. Nel 2025, l’implementazione di questa politica in diverse regioni europee ha evidenziato risultati contrastanti, alimentando il dibattito sulla sua validità e sulla necessità di alternative più efficaci. I numeri parlano chiaro: il calo delle vendite di vino ha raggiunto il 7% in Italia, il 10% in Spagna, il 15% in Francia, il 22% in Germania e addirittura il 34% in Portogallo. Un campanello d’allarme che non può essere ignorato.
La sovrapproduzione di vino non è un fenomeno casuale, ma il risultato di una serie di fattori interconnessi. Innanzitutto, i gusti dei consumatori sono in continua evoluzione, con una crescente attenzione verso bevande alternative e una diminuzione del consumo tradizionale di vino. A ciò si aggiunge una crisi economica che ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie, limitando la spesa per beni non essenziali come il vino. Non vanno poi dimenticate le scorte eccessive accumulate dai distributori durante la pandemia, che ora gravano sul mercato e contribuiscono a deprimere i prezzi. Infine, le vendemmie particolarmente generose degli ultimi anni hanno portato a un aumento della produzione, accentuando lo squilibrio tra domanda e offerta.

- Ottimo articolo! Finalmente qualcuno che mette in luce......
- La distillazione di crisi è solo un cerotto su......
- E se invece di distillare il vino in eccesso, lo......
L’agricoltura biologica come risposta? l’opinione di oscar farinetti
Di fronte a questa crisi, l’agricoltura biologica emerge come una possibile via d’uscita, un modello alternativo che punta sulla qualità, sulla sostenibilità e sul rispetto del territorio. Oscar Farinetti, figura di spicco nel panorama enogastronomico italiano, ha espresso chiaramente la sua visione: “Nel futuro, vorrei che il 100% dei prodotti italiani fossero biologici e se dipendesse da me, dichiarerei obbligatoria l’agricoltura biologica da tre a cinque anni…”. La sua proposta è che l’Italia adotti integralmente il biologico. Egli è convinto che la sostenibilità e il biologico rappresentino la nostra direzione futura. Una provocazione, certo, ma anche un invito a riflettere sulle potenzialità di un’agricoltura che valorizzi le specificità del territorio, promuova la biodiversità e riduca l’impatto ambientale.
La transizione all’agricoltura biologica, tuttavia, non è un processo semplice e immediato. I produttori si trovano ad affrontare numerosi ostacoli, a partire dalla complessità delle procedure burocratiche e dagli elevati costi di certificazione. La mancanza di un supporto adeguato da parte delle istituzioni, sia a livello nazionale che europeo, rappresenta un ulteriore freno alla conversione. Nonostante queste difficoltà, sempre più produttori scelgono di intraprendere questa strada, mossi dalla convinzione che un’agricoltura più sostenibile sia l’unica in grado di garantire un futuro al settore vitivinicolo.
Le difficoltà incontrate dai produttori biologici sono molteplici. Oltre ai costi di certificazione, che possono incidere significativamente sul bilancio di una piccola azienda, si aggiungono le difficoltà legate alla gestione agronomica del vigneto, che richiede competenze specifiche e un approccio diverso rispetto all’agricoltura convenzionale. La lotta contro i parassiti e le malattie, ad esempio, deve essere condotta con metodi naturali, evitando l’utilizzo di pesticidi chimici di sintesi. Ciò richiede una maggiore attenzione e un monitoraggio costante del vigneto, nonché l’adozione di pratiche preventive come la rotazione delle colture e l’utilizzo di varietà resistenti.
Chi beneficia e chi perde nel sistema attuale?
Il sistema attuale, con le sue politiche di sostegno alla produzione e le misure emergenziali come la distillazione di crisi, sembra favorire soprattutto i grandi produttori, che possono contare su economie di scala e su un accesso privilegiato ai finanziamenti europei. Le lobby del settore, spesso in grado di influenzare le decisioni politiche, traggono vantaggio da un sistema complesso e opaco, che rende difficile tracciare i flussi di denaro e individuare i reali beneficiari degli aiuti. A farne le spese sono soprattutto i piccoli produttori, che faticano a competere con i giganti del settore e che si vedono spesso costretti a vendere il loro vino a prezzi stracciati. L’ambiente e i consumatori sono altre due categorie penalizzate da questo sistema. L’agricoltura intensiva, con il suo massiccio utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, contribuisce all’inquinamento del suolo e delle acque, mettendo a rischio la biodiversità e la salute umana. I consumatori, a loro volta, si vedono privati di un prodotto di qualità, sano e rispettoso del territorio.
La concentrazione del potere economico nelle mani di pochi grandi gruppi industriali rappresenta una minaccia per la diversità del paesaggio vitivinicolo europeo. Le piccole aziende, spesso a conduzione familiare, sono custodi di saperi antichi e di tradizioni locali che rischiano di scomparire di fronte all’omologazione dei gusti e alla standardizzazione dei processi produttivi. La perdita di questa ricchezza culturale e paesaggistica sarebbe un danno irreparabile per l’intera Europa.
Non solo i produttori subiscono questo sistema. I consumatori si vedono offrire prodotti di scarsa qualità, derivanti da pratiche agricole intensive che depauperano il suolo e minacciano la biodiversità. Molti di questi vini sono ottenuti con l’utilizzo massiccio di additivi chimici, che ne alterano il sapore e le proprietà organolettiche. Il risultato è un prodotto standardizzato, privo di personalità e di legame con il territorio d’origine.
Verso un nuovo modello vitivinicolo: sostenibilità e resilienza
La crisi del settore vitivinicolo rappresenta un’opportunità per ripensare il modello agricolo europeo e per promuovere un’agricoltura più sostenibile, resiliente e rispettosa del territorio. È necessario superare la logica della produzione a tutti i costi e puntare sulla qualità, sulla diversificazione e sulla valorizzazione delle specificità locali. L’agricoltura biologica, con i suoi principi di rispetto dell’ambiente e della biodiversità, può rappresentare un pilastro di questo nuovo modello. Ma è necessario anche sostenere i piccoli produttori, promuovere la filiera corta e favorire un rapporto più diretto tra produttori e consumatori. Solo così sarà possibile garantire un futuro al settore vitivinicolo europeo e preservare la sua ricchezza culturale e paesaggistica.
Un’altra strada da percorrere è quella dell’innovazione tecnologica, con lo sviluppo di pratiche agricole di precisione che consentano di ridurre l’utilizzo di input chimici e di ottimizzare l’uso delle risorse naturali. L’utilizzo di sensori, droni e software di analisi dei dati può aiutare i produttori a monitorare lo stato di salute del vigneto, a individuare precocemente eventuali problemi e ad intervenire in modo mirato, riducendo gli sprechi e minimizzando l’impatto ambientale. In conclusione, la crisi del settore vitivinicolo è un segnale d’allarme che non può essere ignorato. È necessario un cambio di paradigma, un ripensamento delle politiche agricole europee e un impegno concreto verso un’agricoltura più sostenibile e resiliente. Il futuro del vino europeo dipende dalla nostra capacità di affrontare questa sfida con coraggio e determinazione.
Amici, spero abbiate trovato interessante questo viaggio nel mondo del vino e delle sue sfide. Se volete approfondire, vi consiglio di informarvi sulla lotta integrata, un approccio che mira a ridurre l’uso di pesticidi attraverso un mix di tecniche agronomiche. E se siete appassionati di tecnologia, date un’occhiata all’agricoltura 4.0, che utilizza sensori e droni per ottimizzare la produzione. Riflettete: cosa possiamo fare noi, come consumatori, per sostenere un’agricoltura più sana e rispettosa dell’ambiente?