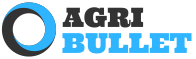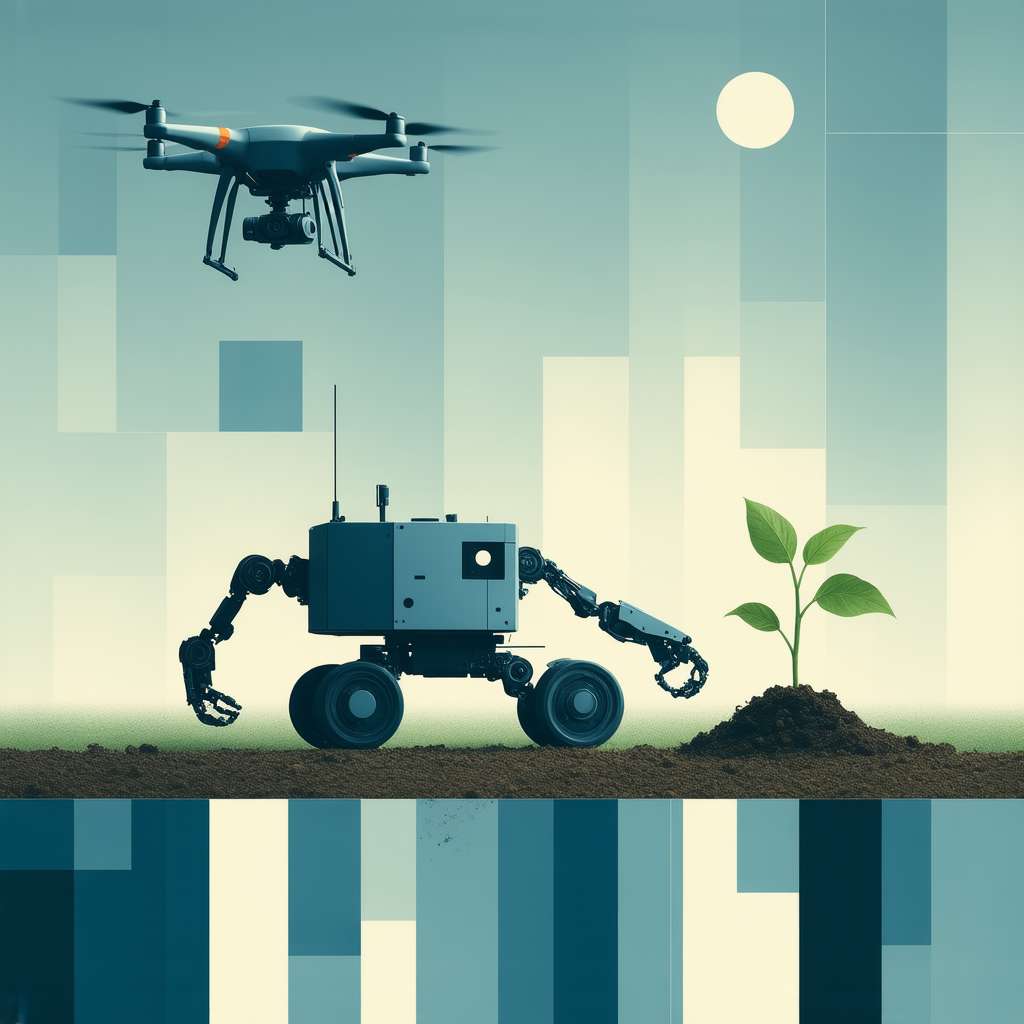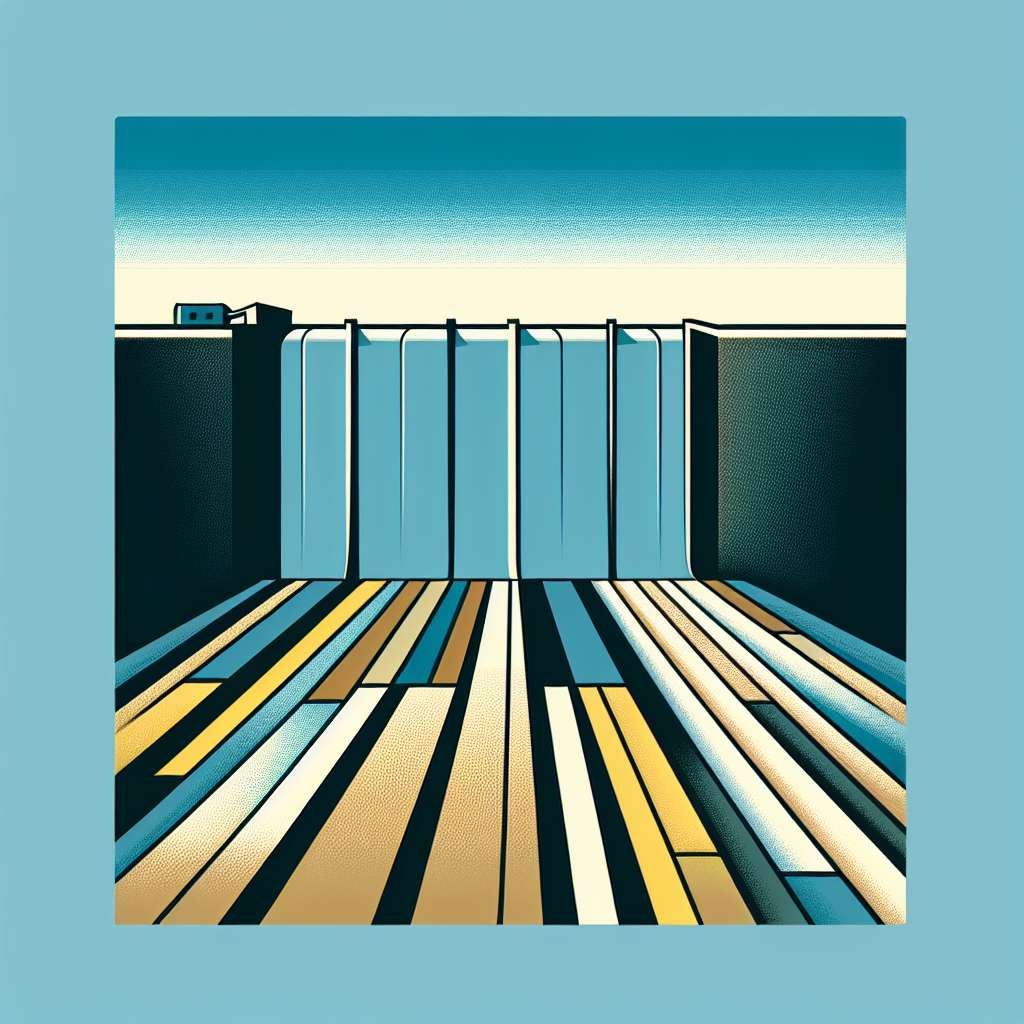E-Mail: [email protected]
- Riduzione del 62% delle emissioni ETS entro il 2030.
- CBAM operativo dal 2023, implementazione completa dal 2026.
- Target climatico 2040: riduzione del 90% delle emissioni.
- Esenzione dall'ESG per circa l'80% delle imprese.
Riforma dell’ETS e il Futuro del Green Deal
Il Green Deal europeo, un’iniziativa ambiziosa volta a trasformare l’Europa nel primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, si trova di fronte a una fase cruciale. Con l’implementazione di misure chiave come la riforma del Sistema ETS (Emissions Trading System) e il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), l’UE si prepara a navigare in un panorama economico e politico in evoluzione. Queste riforme, pur mirando a ridurre le emissioni di gas serra e a promuovere la competitività sostenibile, sollevano interrogativi significativi sulle loro implicazioni per le imprese, i consumatori e la posizione dell’Europa nel contesto globale.
La riforma dell’ETS, in particolare, prevede un innalzamento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni nei settori ETS al 62% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. Questo ambizioso traguardo, unito alla graduale eliminazione delle quote gratuite per le industrie tra il 2026 e il 2034, rappresenta una sfida significativa per le imprese europee. Parallelamente, l’introduzione del CBAM, una “tassa sul carbonio alla frontiera”, mira a creare condizioni di parità tra i produttori europei e i loro concorrenti internazionali, prevenendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

CBAM e ETS 2: Nuovi pilastri della politica climatica europea
Il CBAM, operativo in una fase di transizione dal 2023 al 2025, prevede l’obbligo per gli importatori di dichiarare le emissioni incorporate nei prodotti importati. A partire dal 2026, con l’implementazione completa, sarà richiesto l’acquisto di “certificati CBAM” il cui prezzo rifletterà quello delle quote di emissione nell’ETS. Questo meccanismo, applicato inizialmente a settori ad alta intensità energetica come ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, produzione di energia elettrica e idrogeno, mira a incentivare pratiche industriali più sostenibili a livello globale.
L’ETS 2, d’altra parte, è specificamente progettato per regolamentare le emissioni generate dal riscaldamento degli edifici residenziali e commerciali e dai carburanti utilizzati nei veicoli su strada. A partire dal 2027, i fornitori di combustibili dovranno acquistare permessi di emissione per ogni tonnellata di CO2 rilasciata dai loro prodotti, creando un incentivo economico per la riduzione delle emissioni. Per mitigare potenziali impatti economici eccessivi, l’ETS 2 include un meccanismo di stabilità dei prezzi ed è accompagnato da un Fondo sociale per il clima.
- Ottimo articolo! Finalmente un approccio pragmatico al Green Deal......
- Il Green Deal è una follia! Distruggerà la nostra economia......
- Ma ci siamo chiesti se il problema non sia un altro 🤔...?...
Flessibilità e Realismo: Il Target Climatico 2040
La Commissione Europea si appresta a presentare la proposta legislativa sul nuovo target climatico al 2040, con l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia, per ottenere il consenso degli Stati membri e superare le resistenze politiche, Bruxelles è pronta a introdurre meccanismi di flessibilità, come l’inclusione di strumenti di compensazione internazionale del carbonio e il riconoscimento del contributo delle “rimozioni naturali” di CO2.
Questa maggiore tolleranza a soluzioni adattabili rappresenta un momento cruciale per il percorso futuro del Green Deal europeo. Se da una parte ciò permette di mantenere coeso il blocco europeo, bilanciando le aspirazioni ecologiche con le realtà economiche, dall’altra esiste la possibilità che gli obiettivi ambientali ne escano indeboliti. La discussione accesa sul divieto dei motori a combustione interna previsto per il 2035, per esempio, evidenzia la frizione tra il desiderio di accelerare il processo di decarbonizzazione e la necessità di proteggere la competitività industriale e l’occupazione.
Rinnovata attenzione alla competitività: Un nuovo corso per il Green Deal?
A pochi anni dall’inizio del Green Deal, è diventato lampante che la trasformazione energetica e tecnologica non può essere calata dall’alto per legge, ma deve invece conformarsi alle dinamiche di mercato. I risultati ottenuti tra il 2019 e il 2024, rapportati agli sforzi profusi, appaiono insoddisfacenti. In tale scenario, la Commissione UE ha lanciato la “bussola per la competitività”, definendo l’orientamento strategico per guidare le attività future della Commissione e ponendo un’enfasi rinnovata sul divario di produttività rispetto ad altre potenze economiche.
Il pacchetto “Omnibus I”, presentato il 26 febbraio scorso, introduce ufficialmente una serie di proposte volte a snellire la normativa UE in materia di sostenibilità, con lo scopo di potenziare la competitività, favorire gli investimenti e diminuire l’insieme degli oneri burocratici. Un elemento centrale del pacchetto è la drastica riduzione degli adempimenti di rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance), con un’esenzione estesa a circa l’80% delle imprese europee.
Verso un Futuro Sostenibile: Equilibrio tra Ambizione e Pragmatismo
La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio rappresenta una sfida complessa che richiede un approccio equilibrato tra ambizione e pragmatismo. Le riforme del Sistema ETS e l’introduzione del CBAM e dell’ETS 2 rappresentano passi importanti verso la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo, ma è fondamentale monitorare attentamente le loro implicazioni per le imprese, i consumatori e la competitività dell’Europa nel contesto globale. La flessibilità nel target climatico al 2040 e la rinnovata attenzione alla competitività industriale rappresentano segnali di un cambiamento di rotta, con l’obiettivo di garantire una transizione inclusiva e sostenibile per tutti i cittadini e le imprese europee.
Amici lettori, parlando di agricoltura e di emissioni, è fondamentale ricordare un concetto base: la fotosintesi clorofilliana. Le piante, attraverso questo processo, assorbono CO2 dall’atmosfera e la trasformano in biomassa, rilasciando ossigeno. Un’agricoltura ben gestita può quindi contribuire significativamente a ridurre la concentrazione di gas serra nell’atmosfera.
Ma non fermiamoci qui! L’agricoltura moderna offre soluzioni ancora più avanzate, come l’utilizzo di tecniche di agricoltura conservativa, che riducono la lavorazione del suolo e aumentano la sua capacità di stoccare carbonio. Inoltre, la pratica dell’agroforestazione, che integra alberi e colture agricole, può contribuire a creare veri e propri “pozzi di carbonio”.
Riflettiamo: ogni scelta che facciamo, come consumatori e come cittadini, ha un impatto sull’ambiente. Sostenere un’agricoltura sostenibile e consapevole significa investire nel nostro futuro e in quello del pianeta.
- Comunicato stampa del Consiglio sull'approvazione della riforma ETS 2021-2030.
- Pagina ufficiale ADM sul CBAM, meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
- Dettagli sul Fondo sociale per il clima e il suo finanziamento.
- Dettagli sull'obiettivo climatico europeo per il 2040 e riduzione emissioni.